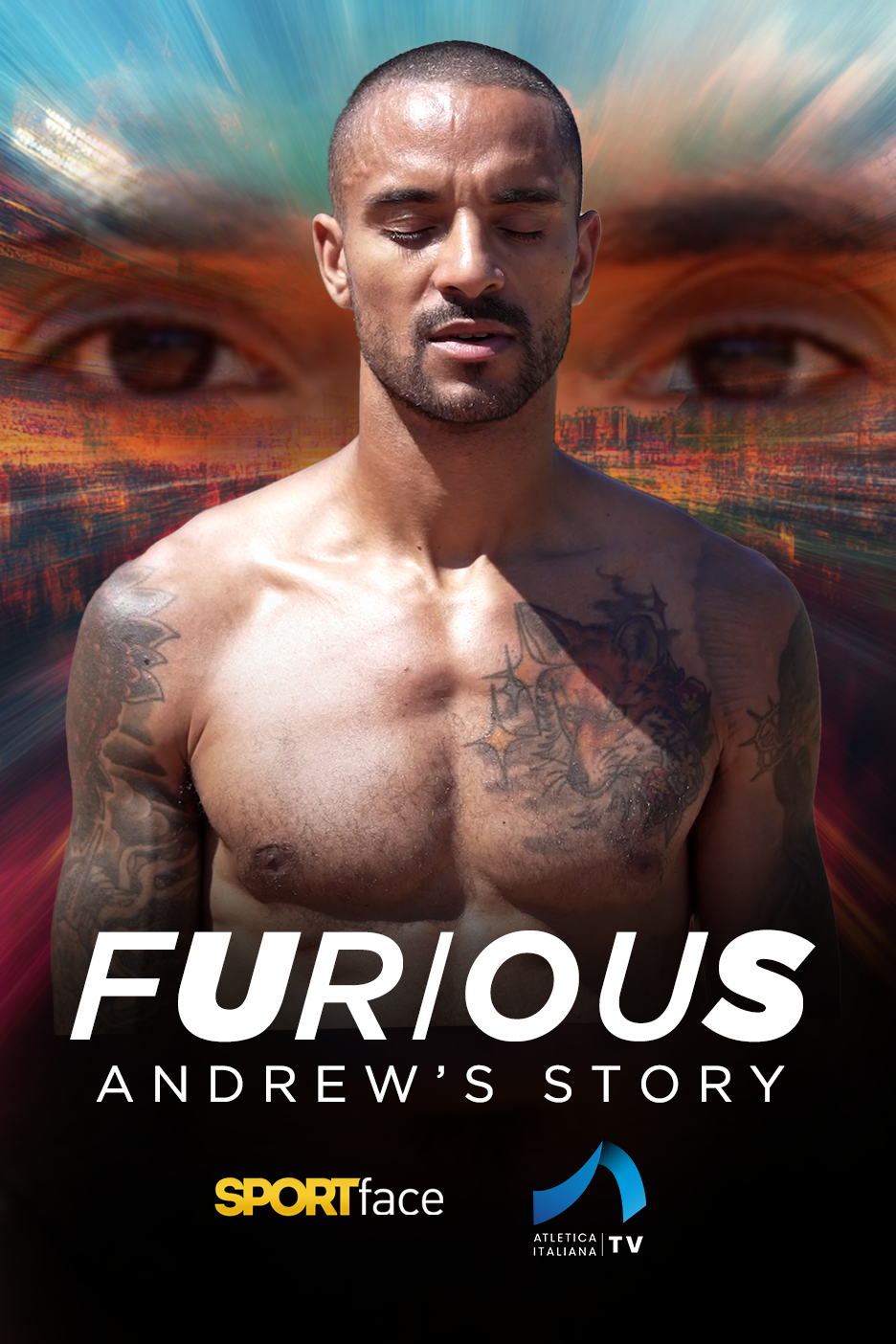Dopo una delle dieci Roma-Castelgandolfo concluse in carriera a braccia alzate – sarà stata quella del 1964, o giù di lì – Abdon Pamich ebbe l’onore di sentir annunciare la propria vittoria da uno speaker eccezionale: il Santo Padre. “Sapete chi ha vinto la gara di marcia?”, chiese quella domenica papa Paolo VI ai fedeli, inaugurando il tradizionale Angelus do mezzogiorno. “Ha vinto Pamich!”.
La marcia di Abdon Pamich è iniziata da molto lontano. Addirittura da un altro Paese che però, prima della guerra, si chiamava ancora Italia. La città di Fiume era l’ombelico d’Europa, e in quegli anni dunque del mondo intero: cosmopolìta, amata e abitata dagli ungheresi, dai cecoslovacchi, dai tedeschi, dagli austraci e naturalmente anche dagli italiani, che negli anni Venti e Trenta vengono chiamati “regnicoli”, perché vengono dal Regno. E il Regno sentitamente ringrazia, anche a livello sportivo, perché Fiume sforna campioni come i fratelli Varglien, campioni del mondo di calcio, o Ezio Loik fuoriclasse del Grande Torino, o un olimpionico come il pugile Ulderico Sergo, oro nei pesi gallo a Berlino 1936. La famiglia Pamich si potrebbe quasi definire benestante: mentre mamma Erenia bada alla casa, papà è un dottore commercialista che non fa mancare nulla ai quattro figli. L’unico guizzo di estro sta in quel curioso nome di origine persiana, Abdon, che vuol dire “servo del Signore”: Abdon e Sennen erano due cattolici persiani martirizzati dall’Impero Romano. E la vocazione al sacrificio sarà una costante nella vita di Abdon Pamich, nella vita e non solo: perché la vita sua e della sua famiglia cambiano il 10 febbraio 1947, quando l’Italia ratifica a Parigi un trattato di pace con le potenze vincitrici della Seconda Guerra Mondiale, e accetta di consegnare alla Jugoslavia una vasta zona di confine che comprende anche la città di Fiume. E a quel punto il Maresciallo Tito fa partire la resa dei conti, dando inizio a quel processo di inderogabile “slavizzazione” che trasforma in indesiderati, o qualcosa di peggio, la gran parte degli abitanti di quel crogiuolo di etnie e culture che viveva in armonia.
È la tragedia delle “foibe”, gli inghiottitoi di formazione naturale creati dallo scorrimento dei fiumi carsici. A migliaia spariranno: croati, tedeschi, italiani non necessariamente coinvolti nel fascismo. Chi può scappa: il papà di Abdon viene inviato a Milano dal governo titino con il mandato di avviare burocraticamente un processo di nazionalizzazione delle principali imprese edili, ma vista la mala parata sceglie di non tornare a casa. E Abdon lo segue, insieme a suo fratello maggiore Giovanni, una notte di fine settembre del 1947. Vanno al mare per l’ultima volta, poi tornano a casa e annunciano: mama, noi andemo via. Escono di casa così come sono vestiti, maglietta e braghini corti, pochi soldi in tasca, e salgono su un treno che li porta a San Pietro del Carso: il piano è prendere la coincidenza con cui raggiungere Trieste, cioè l’Italia. Invece salgono sul treno sbagliato, quello che li riporta a Fiume, e quando se ne accorgono scendono al volo alla prima fermata e iniziano a correre al buio, lungo i binari, per cinque chilometri, sforzandosi di non pensare che potrebbero sparargli. Dopo aver eluso la sorveglianza di un controllore che in croato chiedeva dove fossero diretti, si intrufolano in una comitiva di triestini provenienti dalla Dalmazia e lì, protetti da una coppia che li fa passare come figli, arrivano a destinazione, al Silos di Trieste e da lì nel Centro di Smistamento di Udine. Dopo un paio di giri a vuoto, trovano una collocazione più o meno stabile in un campo profughi dalle parti di Novara, un’ex caserma diroccata, senza finestre, dove quando piove entra l’acqua. L’intimità delle varie famiglie sfollate è garantita da alcune lenzuola tenute su col fil di ferro, che fanno da pareti. Pranzo riso e lenticchie, cena riso e lenticchie. Mentre Giovanni recupera il tempo perduto al liceo, Abdon si accontenta dell’Istituto Tecnico dove diventa geometra (anche se lui voleva fare il Nautico): il diploma gli servirà per lavorare alla Esso. Dopo un anno si ricongiungono al papà, che ha trovato lavoro a Genova; di lì a pochi mesi arriveranno anche la mamma e gli altri due fratelli. Finisce qui la prima parte della vita dell’adolescente Abdon Pamich, che nell’estate dei suoi 13 anni ha messo in mostra notevoli doti di resistenza alla fatica e al dolore. Nelle lunghe camminate che ama fare con suo fratello sulle Alpi Giulie, i più attenti hanno notato che riesce a sfiorare i 50 chilometri al giorno. “Ero pieno di fibre rosse, a riposo andavo a 39 battiti al minuto”.
Negli anni Abdon Pamich ha dato versioni diverse sull’origine della sua folgorazione per la marcia: un cinegiornale d’epoca prima di un film, oppure una 100 chilometri vista dal vivo a Novara, una di quelle gare in cui “parti bambino e arrivi vecchio”. O magari, più semplicemente, quella volta che aveva accompagnato suo fratello a una gara e l’allenatore Giuseppe Malaspina, ex atleta della Nazionale le cui speranze di partecipare ai Giochi di Tokyo 1944 erano state frustrate dalla guerra, gli aveva detto: ti chiami Pamich? E allora perché non provi anche tu? Su strade dissestate, se non proprio su fondi di sanpietrini come nella massacrante Roma-Castelgandolfo di cui sopra, Pamich macina migliaia di chilometri all’anno ed è protagonista per cinque Olimpiadi consecutive, da Melbourne 1956 a Monaco 1972: per un marciatore, un’eternità. Il capolavoro di una carriera è incastonato nel mezzo, Tokyo 1964, sotto una pioggia battente, a combattere con demoni vecchi e nuovi che gli fanno visita lungo le quattro ore di marcia in un paesaggio post-atomico. A cominciare dalla preparazione atletica di una direzione tecnica sorda alle richieste dei marciatori, o semplicemente poco competente: “A Melbourne sono arrivato quarto ma era una gara alla mia portata: la Federazione ci ha stressato, bastava ci facesse riposare”. E a Roma? “A Roma stessa roba, eravamo in allenamento collegiale e si sono dimenticati di noi. Sono arrivato terzo ma praticamente ho fatto tutto nel finale, recuperando tempo e posizioni, quattro minuti su cinque. Era buio, davanti erano scappati in due, forse con la luce e se non fossero stati in coppia li avrei presi. Quello che ha vinto, l’inglese Thompson, non è più arrivato davanti a me”. Stavolta ha deciso di fare di testa sua. Ha smaltito in pochi giorni il fuso orario e gli effetti collaterali delle quattro vaccinazioni a cui ha dovuto sottoporsi come da protocollo per i viaggi intercontinentali. Ma c’è un tempo da lupi, una pioggia incessante degna di Blade Runner, ma prima di Blade Runner, che forse favorisce il britannico Paul Nihill, l’ultimo a restargli incollato dopo che lungo tutti i primi trenta chilometri si sono staccati come foglie d’autunno prima il sovietico Agapov, poi il connazionale Vedikov, poi appunto il campione uscente Thompson, quindi il tedesco Hohne. Poi però c’è un terzo problema, una questione viscerale.
Agli Europei di Stoccolma 1958, sei anni prima, Pamich aveva dovuto accontentarsi del secondo posto alle spalle del sovietico Maskinskov per via di un problema di stomaco che a metà gara lo aveva costretto a fermarsi per due minuti. È la vita agra del marciatore anni Cinquanta e Sessanta: ci si alimenta alla meglio, e a volte capita che il cibo e l’acqua non siano di prima qualità. Succede anche a Tokyo, quando una bottiglietta di tè ghiacciato provoca un piccolo corto circuito intestinale: bisogna agire presto e bene. Le strade sono tutte transennate, abbandonare il percorso per rifugiarsi dietro una siepe sarebbe troppo lungo e controproducente. Si può solo espletare il bisogno en plein air: “Così feci quello che dovevo fare sotto gli sguardi degli spettatori giapponesi, che invece di scandalizzarsi mi applaudirono divertiti”. E Nihill, che aveva approfittato del fuori-programma per prendere la testa, viene subito ripreso e staccato. I secondi diventano cinque, dieci, aumentano di chilometro in chilometro nell’ultimo quinto di gara, quando Pamich è combattuto tra la gioia di quello che sta per succedere e il fastidio per le tante occasioni perse del passato. Così, quando taglia finalmente il traguardo con 19 secondi di vantaggio sul britannico, sembra quasi spezzare con rabbia il filo di nylon che si consegna al vincitore.
Inscritta tra Dordoni e Damilano, la lunga cometa di Pamich è stata “la” marcia per quasi vent’anni, con il suo carico di crampi, vesciche, unghia cadute, dolori corporali, insomma tutto il campionario di sofferenza e retorica che accompagna gli asceti del tacco&punta. 591 gare, 391 vittorie, 11.860 chilometri, due titoli europei, tre vittorie ai Giochi del Mediterraneo, 40 titoli italiani su varie distanze. Una vita di sveglie all’alba per conciliare allenamento e lavoro, con aneddoti dal sapore quasi felliniano. “A Genova mi allenavo sul lungomare, vedevo i tramonti e l’alba: a Capodanno, mentre la gente tornava dal veglione, io marciavo. E sulla Genova-Recco, dopo la solita curva, sentivo sempre la stessa voce. Alle 4 del mattino. Sospettavo si trattasse di uno scherzo del mio amico Dordoni. Per curiosità un giorno mi fermai, e scoprii sulla veranda di una casetta a livello di strada un pappagallo ammiratore”.