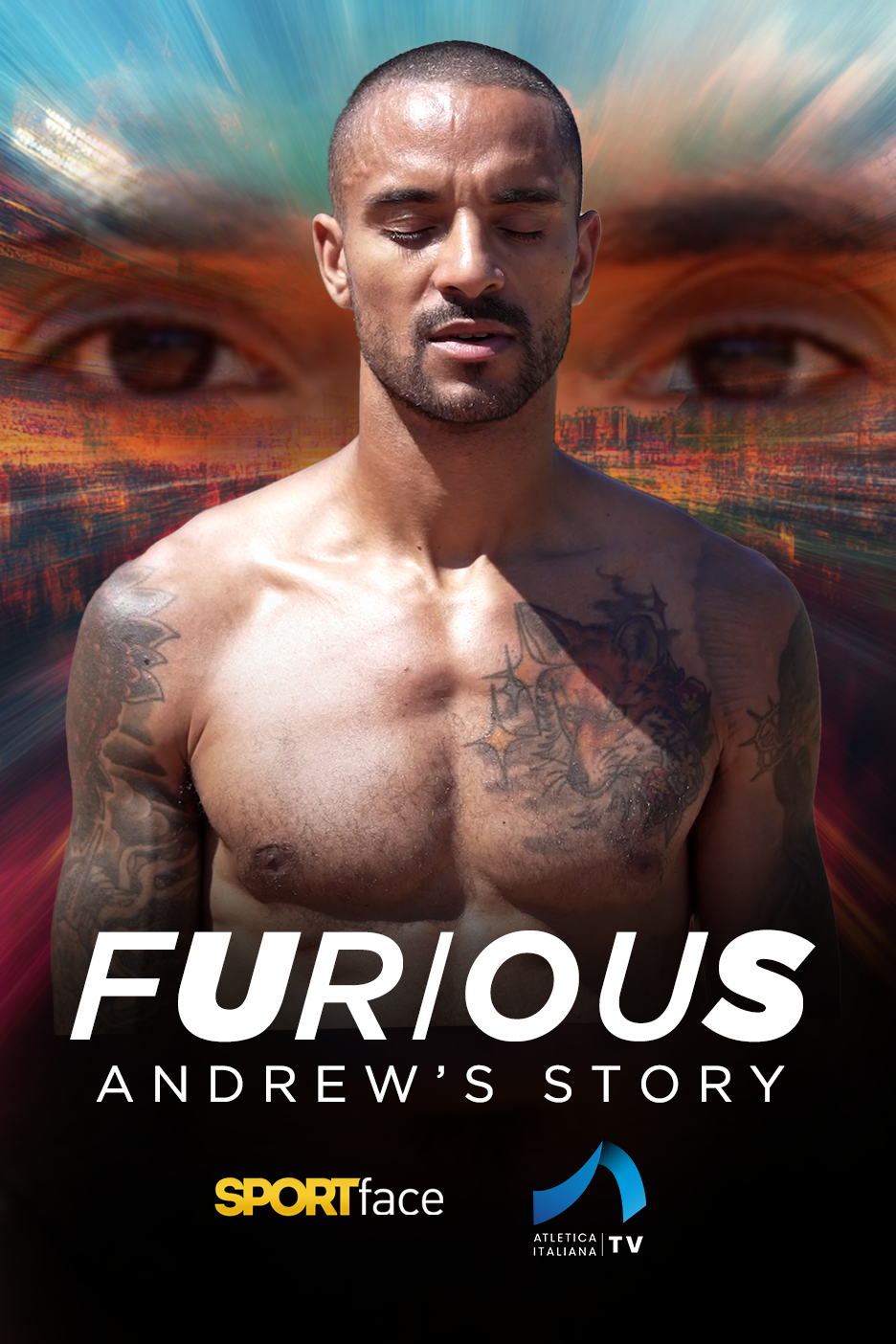L’Olimpiade di Stoccolma del 1912, la quinta dell’epoca moderna, un tratto in comune con quella che andrà di scena a Rio De Janeiro la prossima estate lo detiene: così come accaduto ad Helsinki, nel 1952; queste edizioni succedono Londra nel novero delle ospitanti della manifestazione sportiva più rappresentativa. Come oggi, anche allora venire dopo la città del Big Ben si traduceva in una bella responsabilità, ma se per quanto concerne il 2016 abbiamo un bel punto interrogativo sugli esiti, analizziamo più da vicino cosa successe in Scandinavia 104 anni fa, la storia di un successo, forse in sordina, che pone le proprie basi su quanto accaduto a Londra quarantotto mesi prima. Perché, da persone diligenti, gli svedesi studiarono attentamente e presero ad esempio l’organizzazione britannica, ponendo paletti e attuando delle migliorie, che in un certo qual senso avrebbero anticipato i tempi. La guerra avrebbe cancellato alcuni di questi accorgimenti, ma il ricordo dell’Olimpiade svedese, nelle memorie trascritte di chi le ha vissute e di chi le ha narrate, si rintraccia in settimane ricche di agonismo, ma anche di grande cordialità e buonumore. Gli atleti, pur dilettanti, avevano avuto modo di conoscersi a Londra, per cui una certo feeling si era già creato: la sana rivalità sublimava poi la giusta atmosfera. Sono o non sono i Giochi Olimpici, in fondo, la manifestazione sportiva in cui si incrociano le storie più disparate e avvincenti? Naturalmente sì, per cui, per introdurci e rivivere le emozioni di quel tempo, raccontiamo l’avvicinamento all’evento di tre dei 2.408 iscritti. Profili scelti non a caso.

che per la verità era più vicina ad una mezza, avendo un percorso pari a 24 km – ribadendo il risultato due anni più tardi, quando la distanza era stata avvicinata a quella di una maratona reale, confermandosi l’anno successivo e facendo fermare il cronometro, nell’edizione del 1912, a 2 ore, 52 minuti e 8 secondi: se si considera che a Londra, nei precedenti Giochi, il vincitore aveva impiegato ben 3 minuti in più e che il percorso affrontato da Francisco era stato piuttosto tortuoso, la fiducia nei confronti di Lazaro, in vista di quell’edizione, era molto alta, tanto da concedergli l’onore di essere il primo alfiere della storia olimpica portoghese – nelle precedenti edizioni i lusitani non erano presenti. Il 14 luglio l’attesa era terminata, Francisco stava particolarmente bene. “O vinco o muoio” la leggenda narra avrebbe detto ai suoi compagni di squadra, che lo avrebbero seguito lungo il percorso: sarebbe andata proprio così.
Nomen Omen. Quando nella riserva indiana Sac and Fox Nation venne alla luce – probabilmente nel corso del 1887, oppure l’anno seguente, dato che l’atto di nascita non è mai stato rinvenuto – una coppia di gemelli da una famiglia pellerossa, ma con sangue franco-irlandese, la madre, partorendo uno dei due, vide penetrare, attraverso le fessure della capanna in cui vivevano, un raggio di luna, a seguito del quale esclamò: “Questo si chiamerà Wa-Tho-Huk”, che tradotto dalla lingua degli indiani Sauk, il gruppo di appartenenza, sta a significare “Sentiero Lucente”. Leggenda o meno, il neonato venne poi iscritto agli albi della cittadina di Prague, Oklahoma, come Jacobus Franciscus, o più semplicemente Jim, e che la sua strada sia stata un vero e proprio sentiero lucente, almeno per quanto concerne lo sport, lo racconta la storia. Perché Jacobius Franciscus altri non è che Jim Thorpe, colui che è entrato nella storia dello sport americano come “il più grande atleta di tutti i tempi”, o, meno enfaticamente, e stando ai libri dei record, “il migliore sportivo della prima metà del XX secolo”. Che non fosse invece altrettanto promettente sui banchi da scuola ce lo tramandano le cronache, tanto che, nei primi anni di apprendimento, una grande mano gli venne fornita dal gemello Charles, che purtroppo morì a soli 9 anni per colpa di una polmonite: questo fu un duro colpo per il piccolo Jim, che proseguì un periodo considerevolmente tumultuoso, aggravato dalla morte della madre, fino ai sedici anni quando venne iscritto dal padre alla Carlisle Indian Industrial School, in Pennsylvania, dove conobbe una delle figure cardine dello sport yankee di quegli anni, Glen “Pop” Warner. Valutandone l’ottima struttura fisica, Warner non esitò a provarlo in svariate attività sportive, dando da un lato la possibilità ad un prodigio di trovare la propria dimensione, ma dall’altro di mettere a serio repentaglio quanto di buono si era guadagnato: nel giro di qualche stagione, Jim aveva messo a referto il record di salto in lungo della scuola, ma si era distinto nel football, nel baseball, nel lacrosse ed era stato campione inter-collegiale addirittura nel ballo! Un talento straordinario e difficilmente confinabile in un’unica disciplina: così, quando vennero indetti i trials per la partecipazione all’Olimpiade svedese dell’estate del 1912, Thorpe riuscì a qualificarsi in ben quattro competizioni differenti: salto in alto, salto in lungo, pentathlon e decathlon, un prodigio, e tutto questo a soli 24 (o 25, fate voi) anni. Tutto lasciava intendere che si sarebbe parlato a lungo di lui, tali premesse non potevano trasformarsi in un traumatico nulla di fatto. Così sarebbe stato, nel bene e nel male.

Stoccolma, Luglio 1912. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, gli svedesi, forti anche dell’essere gli unici candidati all’organizzazione di quest’Olimpiade, ebbero tutto il tempo (l’ufficialità giunse nel 1909) e i modi per compiere un lavoro coi fiocchi, compresa l’introduzione di alcune novità, come, per esempio, una primordiale forma di fotofinish oppure la rilevazione decimale dei tempi – molti di queste vennero riprese oltre un decennio più tardi – ma al contempo, per altri motivi, il numero degli sport venne diminuito: il pugilato, vietato in Svezia, venne rimosso, così come il pattinaggio, fino a quel momento presente, ma che fu deciso venisse inserito all’interno del palinsesto dei Nordic Games: in sostanza gli sport furono 14, per 18 discipline e 102 eventi che mettevano in palio medaglie, il tutto per una durata di 3 settimane, comprese tra le cerimonie di apertura di sabato 6 luglio e di chiusura del 27. Grazie alla presenza del Giappone, sono stati i primi Giochi in cui erano rappresentati tutti e cinque continenti, e gli ultimi della Russia per i successivi 40 anni. Soltanto a tre sport fu concesso di non rispettare questi parametri temporali, il tennis, nella sua variante indoor in particolare, che ebbe inizio addirittura il 5 di maggio – ma nei giorni in cui si aprivano i Giochi, a Londra si vivevano le battute finali di Wimbledon – il calcio e il tiro a segno, anticipate invece di sette giorni. Il numero limitato di avvenimenti non intaccò la competitività, e l’intera manifestazione riscosse il consenso di De Coubertin, piuttosto timoroso che non capitasse un altro “caso Italia” – nel 1908 l’Italia, per problemi economici sopraggiunti, non rispettò i patti di ospitare la IV edizione a Roma due anni dopo aver avuto l’ok: Londra così gli subentrò – che si dovette assolutamente ricredere.
Come nelle più recenti edizioni, il ruolo principe tra le discipline fu assunto dalle competizioni acquatiche e dall’atletica:
· nei tuffi il dominio fu bilaterale, con Germania e Svezia sugli scudi, mentre nel nuoto in vasca si impose un personaggio che ha fatto la storia di questo sport, l’hawaiiano Duke Kahanamoku, vincitore dei 100 metri stile libero, oltre che unanimemente considerato l’inventore del surf moderno. Kahanamoku, personaggio dai mille risvolti, ebbe anche una breve parentesi cinematografica, prima di tornare a fare lo sceriffo nelle sue amate Hawaii. Furono anche introdotte le discipline femminili;
· Nelle gare di atletica ci fu un certo predominio da parte degli Stati Uniti, che qualificarono ben 5 atleti su 6 alla finale dei 100 metri, con la vittoria di Ralph Craig, ma il vero protagonista nel macro-ambito “corsa” fu il finlandese Hannes Kolehmainen, campione nei 5.000 metri, 10.000 metri e nella campestre. Curiosa la storia di questo ragazzo, vegetariano per vocazione e muratore di mansione, che, pur rappresentando la Finlandia ai Giochi – che aveva una sua delegazione, ma non era ancora indipendente dalla Russia – vide al momento delle premiazioni (tutte avvenute nel giorno di chiusura) sventolare la bandiera russa, avvenimento che lo portò a dire “avrei desiderato di non aver vinto”. Kolehmainen è universalmente riconosciuto come il predecessore di quella leggenda che risponde al nome di Paavo Nurmi;
· Furono le ultime Olimpiadi in cui atleti non selezionati dalla propria federazione potevano comunque partecipare in maniera privata. E’ il caso di Arnold Strode-Jackson, 21enne inglese, che decise di interrompere prematuramente le sue vacanze estive in Norvegia per salire su un treno e dirigersi alla volta di Stoccolma, per prendere parte alla gara dei 1.500 metri. La corsa sembrava chiusa in favore degli atleti a stelle e strisce, che imponevano il loro passo e cercavano di fare il vuoto. Jackson rimase però attaccato al gruppo di testa e riuscì a superare per un solo decimo Abel Kiviat e Norman Taber, suscitando enorme clamore in quella che venne definita “la più grande gara mai disputata”;
· Negli sport di squadra ebbe grande lustro la Gran Bretagna, che dominò l’Austria nella pallanuoto e, da maestra del football moderno, impose il proprio sigillo ai danni della Danimarca, nell’equitazione furono i padroni di casa a farla da padrone, mentre belgi e ungheresi si spartirono (quasi) tutti gli ori dello scherma, coi russi a prendere i propri allori nella lotta e i norvegesi nella vela. Come usanza in quegli anni, ci fu anche la competizione di tiro alla fune, che doveva inizialmente comprendere ben cinque delegazioni, ma si risolse in un incontro singolo tra la polizia di Stoccolma e quella di Londra: anche in questo caso fu decisivo il fattore “campo”;
· Gli Stati Uniti si imposero nel medagliere con ben 23 ori, contro i 20 svedesi e i 10 dei britannici: l’Italia si fermò a 3: come da tradizione non poteva mancare quello dalla scherma nella finale tutta italiana di fioretto, vinta da Nedo Nadi – che anticipò il suo show di Anversa – su Pietro Speciale, mentre gli altri due giunsero dalla ginnastica, grazie in particolare ad Alberto Braglia – colui al quale la sua città, Modena, ha dedicato lo stadio cittadino – capace di bissare il successo londinese nel concorso individuale, con la riabilitazione a dilettante ottenuta a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione, e di trascinare l’Italia in quello a squadre;
· Vennero inserite però le arti artistiche, successivamente poi abolite e declassate dal rango di discipline olimpiche, con ben cinque concorsi che arrisero in due casi all’Italia (Riccardo Barthelemy – musica, Giovanni Pellegrini – pittura) e regalarono un oro anche all’inventore, Pierre De Coubertin, che sotto pseudonimo gareggiò e vinse con la sua Ode allo Sport. Di queste medaglie, però, non trovate, per quanto detto prima, traccia nel medagliere.
E come andò a finire ai nostri tre eroi?
Medaglia sfumata. Nel Pentathlon moderno George S. Patton pagò a caro prezzo la scelta del calibro 38 nel tiro a segno: la prova consisteva in 20 spari ad un bersaglio, ma i giudici, quando andarono a contare quali punti avesse colpito, trovarono soltanto 17 buchi trapassati, per cui gli attribuirono una penalità di ben 3 colpi. Patton protestò vistosamente, sostenendo che in realtà, grazie alla sua precisione, colpì per 4 volte lo stesso punto, da cui passarono i 3 colpi non rilevati. Non ci fu modo di convincerli – e questo fu uno degli episodi che fece capire come un tabellone di carta non fosse esattamente la soluzione migliore per questa tipologia di gara – per cui George fu costretto a partire con un forte handicap, risultando soltanto ventunesimo al termine della prima prova. Come il suo proverbiale carattere voleva, il futuro generale d’acciaio non si lasciò prendere dallo sconforto e cominciò la sua rimonta proprio a cominciare dalla disciplina meno amata, il nuoto, dove colse un settimo posto, raggiunse poi la quarta posizione nella scherma – dove fu l’unico a sconfiggere lo sciabolatore francese Jean de Mas Latrie – il sesto posto nell’equitazione e addirittura il terzo nella prova conclusiva di corsa. Differentemente dalle manifestazioni multidisciplinari attuali, dove ciascuna gara ha una conversione, se siano tempi o misure, in un sistema di punteggi che crea una graduatoria, all’epoca la classifica finale era determinata dalla somma delle posizioni nelle cinque prove: chi totalizzava il punteggio minore, otteneva la medaglia d’oro. Il caso volle che i primi tre classificati nella prova del tiro a segno, furono anche i tre a salire sul podio, seppur con ordine diverso: lo svedese Gosta Lilliehook, con un punteggio di 27, superò i connazionali Gosta Asbrink (28) e Georg de Laval (30), ma i due appena fuori dal podio conseguirono risultati di gran lunga migliori nelle ultime quattro gare. La quarta piazza spettò all’ennesimo svedese, Ake Gronhagen (35, ma diciottesimo al tiro), mentre quinto, primo dei non appartenenti alla nazione ospitante, fu proprio il nostro Patton, che con un totale di 41 punti avrebbe avuto bisogno di un posizionamento nei primi 10 al tiro per ottenere una medaglia: per lui era andata proprio così. Un podio sfumato che George si sarebbe potuto guadagnare nell’Olimpiade successiva, quella di Berlino del 1916, che a causa della I Guerra Mondiale non venne poi disputata, ma per cui si era già guadagnato il diritto a partecipare. Così, da quel momento, nel futuro di Patton non ci sarebbe stato più spazio per l’attività sportiva, ma soltanto per la gloriosa carriera militare.
“Lei è il più grande atleta del mondo” “Grazie Re”. Jim Thorpe, dopo aver disatteso qualsiasi invito da parte del capo-spedizione di allenarsi per le gare – “Dormivo, sì ma sognavo di allenarmi”, rispondeva quasi in scherno – trasmetteva la sensazione di non avere alcuna preoccupazione, nonostante dovesse prendere parte a ben quattro eventi. Il primo fu il pentathlon, quello tradizionale, dove vinse quattro gare (salto in lungo, 200 metri, lancio del disco e 1.500 metri) e giunse terzo nel giavellotto, attrezzo che prima di quell’anno non aveva mai preso in mano. Non ebbe tempo di festeggiare che immediatamente dovette trovare le forze per qualificarsi per il salto in alto, dove poi arrivò quarto, e nel salto in lungo, in cui giunse “solo” settimo, prima del gran finale, il decathlon, dove il suo dominio fu netto, ma non come nel
pentathlon, con quattro manches finite nel suo palmares. Tuttavia superò il secondo in classifica, Hugo Wieslander, atleta di casa, di oltre 700 punti e chiuse a 8.412, che rimase un punteggio imbattuto per un paio di decadi e che, se paragonato a quelli attuali (il record, registrato nel 2015, da Ashton Eaton, è di 9.045), non sfigura affatto, soprattutto se facciamo riferimento ad un altro fattore: Jim fu costretto ad usare delle scarpe trovate nella spazzatura, poiché le sue gli erano state rubate, che non erano nemmeno dello stesso numero, essendo una evidentemente più piccola: dovette ovviare con alcune paia di calzini, come alcune fotografie dell’epoca testimoniano. Quando il Re Gustavo V lo premiò, non poté esimersi dal rivolgergli un complimento sentito “Lei è l’atleta più meraviglioso che io abbia mai visto” a cui Thorpe non seppe rispondere se non con un laconico “Grazie Re”, tradendo una certa emozione. Non ancora esausto, Jim prese parte alla partita di baseball che venne giocata in via sperimentale, poiché la disciplina dell’ Hit&Run non era ancora nel programma olimpico. Tragica casualità, perché dopo averlo festeggiato a dovere, da New York fino alla Pennsylvania, il 22 gennaio del 1913, Roy Johnston, giornalista ed editor del Worcester Telegram, annunciò in pompa magna di essere venuto a conoscenza che Thorpe, l’eroe Thorpe, nel corso del 1910, aveva giocato a baseball a Rocky Mountain, North Carolina, e, soprattutto, aveva percepito 15 dollari a settimana, cifra che lo aveva fatto innalzare allo status di professionista. E poiché a differenza di Braglia, Thorpe non aveva mai ricusato tale passato, il CIO, di concerto con il Comitato Organizzativo svedese, tolse immediatamente le due medaglie a Jim – “Fu una leggerezza, molti altri futuri olimpionici avevano fatto come me, ma ebbero l’accortezza di giocare sotto falso nome, io invece non lo feci. Ma dovevano essere più clementi: ero ancora uno scolaro indiano che nulla conosceva di queste faccende” – e diede il là ad una querelle che avrebbe trovato conclusione soltanto nel 1983, quando il Comitato Olimpico riconsegnò a Jack Thorpe, il figlio, le due medaglie, concedendo all’illustre padre l’onore del successo ex-aequo nelle due discipline. Jim, nel frattempo, era trapassato da 30 anni, costretto a vivere in una roulotte nella Contea di Los Angeles, dove ebbe un infarto mentre cenava con la terza moglie. La fine infausta di un campione che tanto facilmente aveva trovato se stesso nello sport, ma altrettanto difficilmente era riuscito a farlo nella vita di tutti i giorni.
Caldo asfissiante. Uno dei fattori che sorprese in maniera decisa molti dei concorrenti in gara furono le condizioni torride, quasi proibitive, in cui si disputarono i Giochi. Era sì piena estate, ma l’immagine di una stagione comunque godibile, nella proverbialmente fredda Scandinavia, era vivida nel pensiero comune; invece, in maniera particolare la mattina di domenica 14 luglio, il termometro segnava temperature stranamente elevate, superiori ai 30 gradi: non il clima ideale per i moderni emuli di Fidippide, che sotto quel solleone avrebbero dovuto completare i 40 chilometri e 200 metri (all’epoca non veniva ancora usata la misura “ufficiale”) per aggiudicarsi, o quantomeno concludere, la gara che più ricorda gli antichi Fasti delle vecchie Olimpiadi. Francisco Lazaro aveva già in passato sofferto di qualche problema di salute, per cui aveva timore che, quel caldo elevato, lo avrebbe potuto debilitare: cercando di ovviare al problema, commise un errore sciocco, che se avesse confidato a qualcuno avrebbe certamente evitato. Per il timore delle ustioni, cosparse molte parti del suo corpo con della cera, che impedì la normale traspirazione della pelle, causando uno stato, coll’andare del tempo, di disidratazione irreversibile. I suoi cinque compagni di squadra, che si erano appostati lungo il percorso come detto, erano ben contenti di vedere come, Francisco, tra il quindicesimo e il venticinquesimo chilometro, avesse recuperato ben nove posizioni e, nonostante fosse solo diciottesimo, il distacco dalla testa della corsa non fosse così incolmabile, ma cominciarono a preoccuparsi quando non lo videro passare al passaggio dei 35. Si allarmarono, si fecero accompagnare anche dall’ambasciatore portoghese in Svezia, e lo trovarono su una collina, attorno al ventinovesimo chilometro, completamente privo di conoscenza. Provarono a dargli del ghiaccio, lo trasportarono urgentemente in ospedale, dove inizialmente pensarono erroneamente ad una meningite, ma la mattina del giorno seguente spirò: fu il primo caso di morte nel corso di un avvenimento olimpico. E quella maledetta profezia “Ganho o morro” si svelò tristemente veritiera: è alquanto sconcertante come una delle pagine più nere dello sport si leghi ad una delle più divertenti, perché, lungo lo stesso percorso, si stava creando il mito di Shizo Kanakuri, il padre della maratona giapponese: Shizo, giunto dopo quasi tre settimane di viaggio in Svezia con il treno, si era ben preparato e, non soffrendo apparentemente il caldo, aveva impostato una gara d’attacco, che lo vedeva accreditato di un ottimo tempo. Questo fino al trentesimo chilometro, quando si fermò per bere un succo di frutta offertogli da uno spettatore che stava seguendo la gara comodamente seduto nel giardino della sua abitazione (all’epoca, per cercare in maniera avventata di rivivere il clima del passato, non esistevano dei veri punti di ristoro): spossato e stanco, 
Un intrecciarsi di storie dai caratteri e dagli esiti opposti, unita a quella del vincitore McArthur, che venne accusato di non aver atteso ad un accordato stop di rifornimento il secondo classificato, il connazionale Gitsham, che ben riassumono perché l’Olimpiade è un evento irripetibile. Si può vincere, si può fallire, si può entrare nel cuore pur non avendo ottenuto nulla e si può perdere tutto. Esattamente come nei momenti importanti della vita.